Teoria del discorso
 Share
Share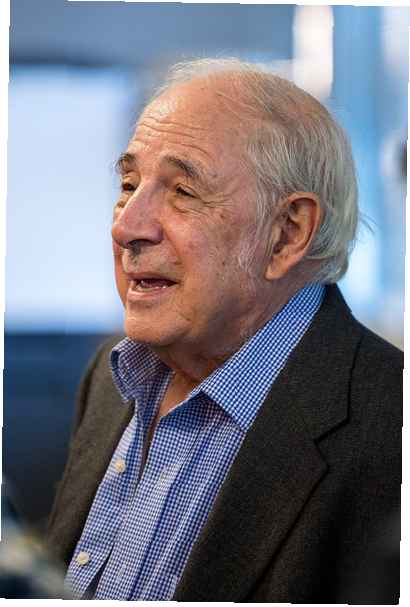
La teoria dell'atto vocale è un sottocampo della pragmatica che studia come le parole vengono utilizzate non solo per presentare informazioni ma anche per realizzare azioni.
La teoria del act act è stata introdotta dal filosofo di Oxford J.L. Austin nel Come fare le cose con le parole e ulteriormente sviluppato dal filosofo americano J.R. Searle. Considera il grado in cui si dice che le espressioni compiono atti locutionary, atti illocutionary e / o perlocutionary.
Molti filosofi e linguisti studiano la teoria degli atti linguistici come un modo per comprendere meglio la comunicazione umana. "Parte della gioia di fare la teoria degli atti linguistici, dal mio punto di vista strettamente in prima persona, sta diventando sempre più promemoria di quante cose sorprendentemente diverse facciamo quando parliamo", (Kemmerling 2002).
I cinque punti Illocutionary di Searle
Il filosofo J.R. Searle è responsabile dell'elaborazione di un sistema di categorizzazione degli atti linguistici.
"Negli ultimi tre decenni, la teoria degli atti linguistici è diventata un ramo importante della teoria contemporanea del linguaggio grazie principalmente all'influenza di [JR] Searle (1969, 1979) e [HP] Grice (1975) le cui idee sul significato e sulla comunicazione hanno stimolato la ricerca in filosofia e nelle scienze umane e cognitive ...
Dal punto di vista di Searle, ci sono solo cinque punti illocutionary che gli oratori possono raggiungere sulle proposizioni in una frase, vale a dire: i punti illocutionert assertivo, commissivo, direttiva, dichiarativo ed espressivo. Gli oratori ottengono il punto assertivo quando rappresentano come stanno le cose nel mondo, il punto commissivo quando si impegnano a fare qualcosa, il punto di direttiva quando tentano di convincere gli ascoltatori a fare qualcosa, il punto dichiarativo quando fanno cose nel mondo al momento dell'espressione solo in virtù del dire che fanno e il punto espressivo quando esprimono il loro atteggiamento nei confronti di oggetti e fatti del mondo (Vanderkeven e Kubo 2002).
Teoria del discorso e critica letteraria
"Dal 1970 la teoria degli atti linguistici ha influenzato ... la pratica della critica letteraria. Quando applicata all'analisi del discorso diretto da parte di un personaggio all'interno di un'opera letteraria, fornisce un quadro sistematico per identificare i presupposti, le implicazioni e gli effetti non detti degli atti linguistici [che] i lettori e i critici competenti hanno sempre tenuto conto, sottilmente ma in modo non sistematico.
La teoria dell'atto vocale è stata anche utilizzata in modo più radicale, tuttavia, come modello su cui rifondere la teoria della letteratura ... e soprattutto ... le narrazioni in prosa. Ciò che l'autore di un'opera immaginaria, o ciò che il narratore inventato dall'autore narra, è ritenuto costituire una serie di asserzioni "pretese", che sono intese dall'autore e comprese dal lettore competente, essere libere dall'ordinario di un oratore l'impegno per la verità di ciò che afferma.
All'interno della cornice del mondo immaginario che la narrazione imposta in tal modo, tuttavia, le espressioni dei personaggi immaginari - che si tratti di affermazioni o promesse o voti coniugali - sono ritenute responsabili di normali impegni illocutori "" (Abrams e Galt Harpham 2005 ).
Critiche alla teoria degli atti linguistici
Sebbene la teoria degli atti linguistici di Searle abbia avuto un'enorme influenza sugli aspetti funzionali della pragmatica, ha anche ricevuto critiche molto forti.
La funzione delle frasi
Alcuni sostengono che Austin e Searle basavano il loro lavoro principalmente sulle loro intuizioni, concentrandosi esclusivamente su frasi isolate dal contesto in cui potevano essere utilizzate. In questo senso, una delle principali contraddizioni della tipologia suggerita da Searle è il fatto che la forza illocutoria di un atto linguistico concreto non può assumere la forma di una frase come la considerava Searle.
Piuttosto, i ricercatori suggeriscono che una frase è un'unità grammaticale all'interno del sistema formale del linguaggio, mentre l'atto linguistico implica una funzione comunicativa separata da questa "(Martínez Flor e Usó-Juan 2010).
Aspetti interazionali della conversazione
"Nella teoria dell'atto linguistico, l'ascoltatore è visto come un ruolo passivo. La forza illocutoria di un particolare enunciato è determinata in relazione alla forma linguistica dell'enunciato e anche all'introspezione sul fatto che le condizioni di felicità necessarie, non ultimo in relazione a le convinzioni e le sensazioni di chi parla sono soddisfatte e quindi gli aspetti interazionali sono trascurati.
